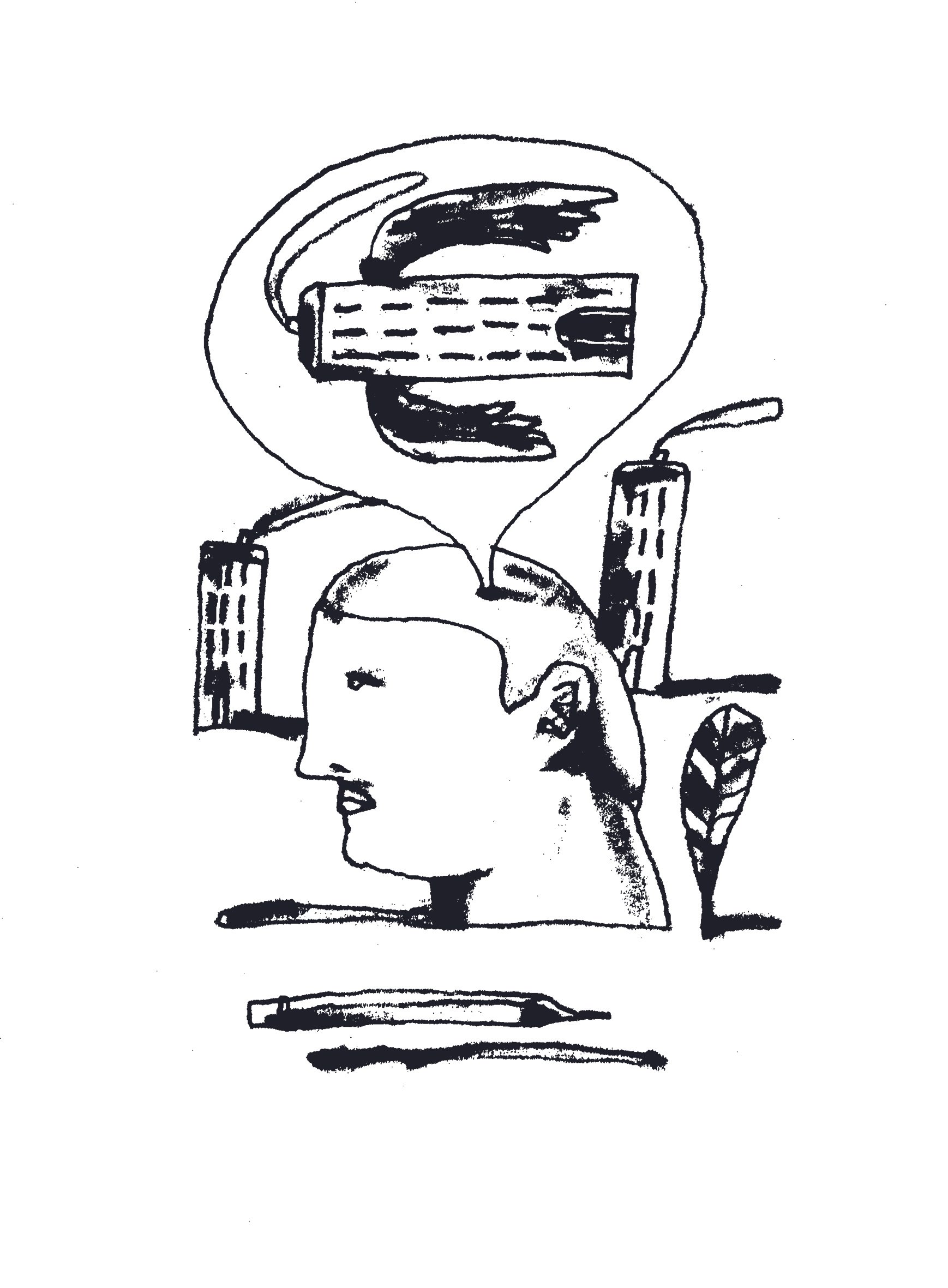La casa che amo
Biennale Architettura 2025 Gens
Identità domestiche. Se la stanzialità non è più paradigma
di Alfonso Femia
La dimensione fisica ed emotiva de “La casa che amo” si sta trasferendo dall’intimo domestico a un domestico urbano collettivo.Gli oggetti e le memorie urbane diventano individualmente identitarie: la casa che amo, gli spazi comuni che amo, la città che amo. La nuova “casa che amo” deve accompagnare i passaggi sociali dei cittadini, bilanciando la massimizzazione del comfort con la temporaneità dell’uso, la trasformabilità e la riusabilità per altre tipologie di utenti.
È una “casa-città”, una “casa-territorio”.
©AF517 & Tapiro, Illustrazione tratta da "La Città Buona"
Da dove nasce questa mutazione? Abitare e spostarsi sono azioni interdipendenti. Non c’è contrapposizione tra i due concetti, ma alternanza e sequenza.
Persone che si spostano da una metropoli all’altra senza avere un posto di lavoro fisso o una casa, una condizione temporanea e provvisoria, una scelta di vita per un periodo limitato: sta diventando una situazione diffusa, in esordio con i Millennial e in consolidamento con la Gen Z.
e è questo il modello contemporaneo di adattamento alle rivoluzioni sociali ed economiche, non solo per ragioni di emergenza e urgenza - catastrofi naturali, esilio politico - ma semplicemente per studio e lavoro, la casa si sta modificando per reagire alla mobilità e al nomadismo.
Dunque, l’architettura non può ignorare che la realtà sociale flessibile e mutante di un’umanità perennemente delocalizzata esige nuove forme di abitabilità, secondo “una diversa concezione del costruire non come realizzazione, ma come condizione dl pensiero” (Jacques Derrida, che già nel testo del 1985 “Maintenant l’architecture” pensa a un’architettura che inventi “un nuovo abitare che non corrisponda più alle vecchie condizioni”).
©AF517 & Tapiro, Illustrazione tratta da "La Città Buona"
Dopo anni di architettura creatrice di nuovi bisogni, è necessario ora riflettere su quali siano invece i reali bisogni dell’essere umano, non assoluti, non codificati, ma specifici di un determinato momento nel tempo e nello spazio del mondo
La casa sta diventando d’uso temporaneo a causa di dinamiche sociali che obbligano le persone a continui cambiamenti del luogo di residenza per adeguarsi alle esigenze delle nuove comunità urbane.
QUANDO IL NOMADISMO ASPIRA ALLA STANZIALITÀ
Per certi aspetti, il nomadismo contemporaneo ha declinazioni che convivono con la dimensione statica: la globalizzazione genera luoghi uguali in regioni e paesi diversi: la dimensione dell’abitare e del vivere si replica e il nomadismo diventa un’esperienza finita, con poca o nulla attitudine all’esplorazione. Si tratta di luoghi identici con un’identità fondata su dei parametri ben determinati: luoghi del lusso, mall o centri commerciali, spazi attrezzati di consumo e di divertimento, snodi di comunicazione, in particolare gli aeroporti, non-luoghi dove l’uomo nomade ritrova un mondo, allo stesso tempo, artificiale e familiare, attrezzato da un punto dei suoi nuovi bisogni digitali. Questo processo di moltiplicazione dei luoghi si è portato dietro importanti mutazioni anche tra le culture relegate ai confini del mondo occidentale. Il cambiamento climatico è un altro motore che genera nomadismo, ma anche in questo caso si tratta di un nomadismo che cerca approdo e stabilità. L’architettura d’emergenza è un’altra espressione del nomadismo, che esce dalla logica assistenziale estemporanea e lavora sull’accoglienza e sul comfort in condizioni estreme.
©AF517 & Tapiro, Illustrazione tratta da "La Città Buona"
Il cambiamento climatico è un altro motore che genera nomadismo, ma anche in questo caso si tratta di un nomadismo che cerca approdo e stabilità. L’architettura d’emergenza è un’altra espressione del nomadismo, che esce dalla logica assistenziale estemporanea e lavora sull’accoglienza e sul comfort in condizioni estreme.
©AF517 & Tapiro, Illustrazione tratta da "La Città Buona"
NOMADISMO … NOMADE
Esiste poi un nomadismo in emersione crescente dalle nuove professionalità digitali, che coniuga la libertà sia geografica, sia organizzativa del lavoro alla ricerca di condizioni ambientali favorevoli e di habitat temporanei. Il nomade digitale sceglie luoghi isolati e lontani dagli insediamenti urbani. E ancora un nomadismo urbano: abitare, tempo libero e arte contemporanea sembrano essere i sostantivi che, a Parigi come ad Amsterdam, a Londra come a New York, sono in grado di stimolare il ridisegno di interi quartieri, attraverso il ripensamento degli usi e delle funzioni che vanno determinando le nuove topografie metropolitane. Le città si trasformano, non (solo) per le strategie di rigenerazione urbana, ma per gli orientamenti bottom up. L’abitare diventa aggregazione, condivisione, rotazione.
NOMADISMO E CITTÀ
Per questo tipo di abitare architettura e immobiliare non sono adeguati. L’equazione città – nomadismo è la più difficile da risolvere. Tutto il real estate si ancora a una solida base di residenza/famiglia estesa per tutta la vita. È necessario che gli operatori privati e le amministrazioni pubbliche si orientino verso trasformazioni urbane capaci di ripensare gli usi di intere aree urbane dismesse, come ex zone produttive, reti in disuso e strutture portuali, predisponendole ad accogliere funzioni museali, stazioni espositive, strutture sociali e quant’altro, capaci di diventare a loro volta incubatori di ulteriori trasformazioni. Nelle periferie, “l’archeologia del moderno” è capace di rinnovare il ruolo di intere parti di città dimenticate e di riabilitare evolvendo.
La cultura italiana predilige riusare gli edifici storici per l’arte e la cultura, ma la trasformazione secondo questo modello svuota i paesaggi storici urbani dove non si sperimenta più l’attesa e la sorpresa.Le città sono un paesaggio esteso, che deve essere attivo in ogni sua parte, a servizio dei “nuovi cittadini”. In questa interpretazione aggiornata, le aree periferiche possono essere interpretate e sviluppate con elementi di qualità diffusa.
©AF517 & Tapiro, Illustrazione tratta da "La Città Buona"